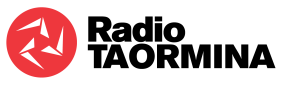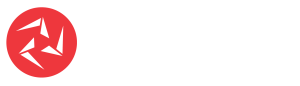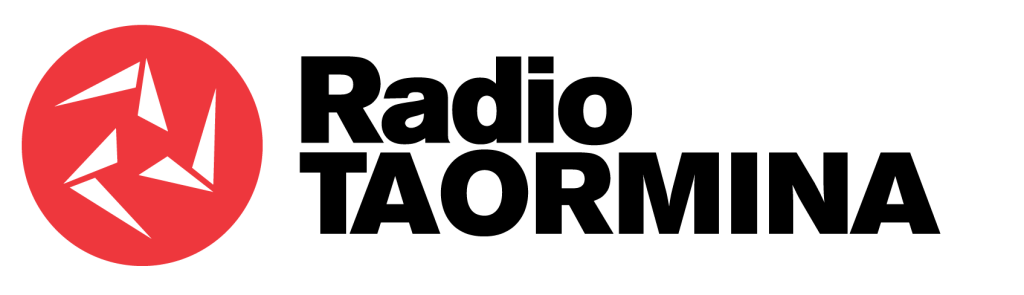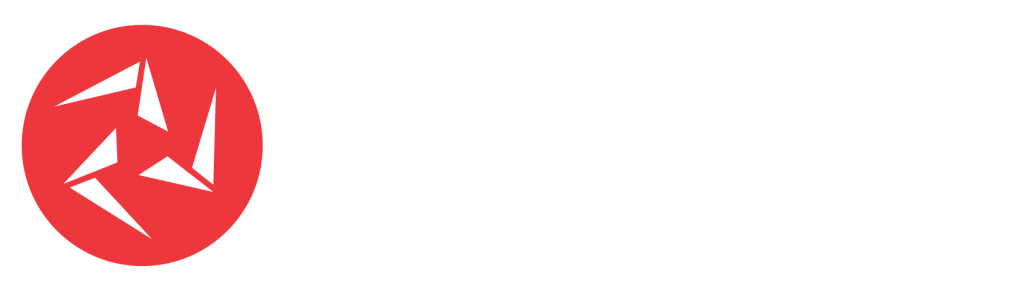MESSINA – Risalendo la Strada Statale che porta ai Colli di Messina, poco dopo la “Casa di Riposo delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Don Bosco” a Piano Rama, si trova la grotta-eremo che, secondo la tradizione, ospitò l’eremita Sarrizzo. Questa piccola cavità di forma rettangolare presenta una volta a botte e mura in mattoni, con al centro della parete di fondo una croce greca scavata nella pietra e altre due più piccole incise in basso.
Sulle pareti interne si notano iscrizioni greche di difficile lettura, presumibilmente di epoca bizantina o normanna. Tra i graffiti, spiccano le date 1660 e 1766 insieme al nome Gius. Midili, segni tangibili della lunga frequentazione del sito. La scoperta e lo studio dell’eremo si devono agli “Amici del museo”, un gruppo di ricerca guidato dal compianto Franz Riccobono e Nino Principato.
Tuttavia, la natura selvaggia dei Peloritani ha spesso reso negli anni difficile individuare e accedere all’eremo. La vegetazione rigogliosa, composta da felci, rovi e cespugli di elica, tende a ricoprire rapidamente il sito, rendendolo invisibile. Recentemente, grazie all’intervento di volontari e appassionati di trekking, tra cui padre Giovanni Lombardo, è stato possibile ripristinare il sentiero che conduce alla grotta.
Gli eremi nascosti dei Peloritani: il contributo del professor Saro Abbate
Gli eremi e le grotte del territorio messinese continuano a svelare la loro storia grazie al lavoro di esperti e studiosi. Tra questi, il professor Saro Abbate, geologo e studioso delle cavità rupestri, ha condiviso la sua esperienza e il suo punto di vista sull’importanza della riscoperta di questi luoghi di culto dimenticati.
“Da tempo ero a conoscenza dell’esistenza di questo eremo attraverso la letteratura settoriale”, spiega Abate, “ma non ero mai riuscito a raggiungerlo. Ho tentato diverse volte, ma l’impresa si è rivelata quasi impossibile: la difficoltà nel localizzarlo e il progressivo abbandono delle campagne hanno reso l’accesso estremamente complicato, a causa della fitta vegetazione di rovi e spine. Per questo motivo, il lavoro svolto da padre Lombardo e dal suo gruppo è encomiabile, non è facile rendere nuovamente fruibili siti come questo”.
Il territorio dei Monti Peloritani, così come le aree di Rometta e Monforte San Giorgio, è caratterizzato dalla presenza di numerosi ipogei artificiali, facilmente scavabili dall’uomo. “Alcuni di questi ambienti”, prosegue Abate, “vennero utilizzati come tombe in epoche remote, mentre altri furono realizzati successivamente per scopi abitativi e religiosi. Con l’arrivo in Sicilia dei monaci provenienti dal Medio Oriente, si diffuse la pratica di adattare grotte e anfratti naturali per la vita eremitica. Tracce di questa presenza si ritrovano in diverse zone, come le Masse e i dintorni di Gesso”.
L’eremo in questione, secondo lo studioso, rappresenta un caso unico per il territorio: “L’elevata frequentazione da parte dei monaci è testimoniata non solo dalle strutture scavate nella roccia, ma anche dalla presenza di iscrizioni bizantine. Il mio auspicio è che possa essere studiato in maniera più approfondita da specialisti del settore. La decifrazione delle iscrizioni, scritte in parte in greco e in parte in latino, potrebbe contribuire a una migliore comprensione del contesto storico e religioso di questo luogo. Inoltre, sarebbe auspicabile che il sito venisse reso accessibile agli studenti e agli appassionati di archeologia, per preservarne la memoria e valorizzarne il significato storico”.